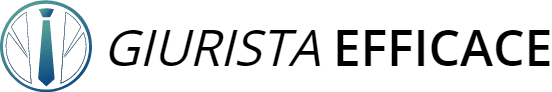Con atto di citazione notificato l’11 giugno 2014 B.B., A.A., D.D. e C.C. convenivano davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Generali Italia Spa quale impresa designata dal FGVS, F.F., + Altri Omessi, questi ultimi in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minorenne G.G., quali eredi di H.H., nonchè H.H., per accertare che I.I. figlio di B.B. e A.A., fratello di D.D. e nipote di C.C. – era morto il 15 aprile 2011 in un sinistro stradale quale trasportato su un veicolo condotto da H.H. (anch’egli deceduto) e privo di copertura assicurativa, e conseguentemente ottenerne, in proprio e quali eredi, il risarcimento dei danni.
La compagnia si costituiva, resistendo, e tra l’altro adducendo la sussistenza di un’ipotesi di caso fortuito e/o di concorso di colpa di H.H. e tale L.L. ex art. 2054 c.c.; proponeva in subordine azione di regresso nei confronti degli eredi di H.H., cioè F.F., O.O., Bencivenga Raffaele, E.E., questi ultimi in proprio e quali legali rappresentanti della figlia minorenne G.G., nonchè nei confronti di M.M., i quali si costituivano – tranne il M.M. che restava contumace – resistendo e concludendo perchè fosse affermata l’esclusiva responsabilità del L.L. e comunque perchè fosse contenuta la condanna risarcitoria entro i limiti del valore dei beni accettati con beneficio d’inventario.
Concessa dapprima una provvisionale di Euro 400.000, con sentenza n. 647/2017 il Tribunale condannava la compagnia a risarcire i danni, detratto l’importo della provvisionale, nella misura di Euro 530.711, e accoglieva la domanda di regresso nei limiti dei beni accettati con beneficio d’inventario nei confronti di N.N. e E.E. – in proprio e quali responsabili della minore G.G. – F.F. e O.O..
Generali proponeva appello, cui resistevano B.B., A.A., D.D. e C.C., le altre parti rimanendo contumaci.
Con sentenza del 26 giugno 2020 la Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame, condannava l’appellante a corrispondere la somma di Euro 184.150,05 a B.B., la somma di Euro 182.753,04 a A.A., la somma di Euro 45.000 a D.D. e la somma di Euro 22.500 a C.C., oltre accessori, previa detrazione di quanto versato a titolo di provvisionale, e condannava gli appellati alla restituzione delle somme in esubero già eventualmente riscosse.
Hanno presentato ricorso sulla base di cinque motivi B.B. in proprio e quale procuratrice speciale di C.C., nonchè A.A. e D.D.. La compagnia si è difesa con controricorso. Entrambi hanno depositato memoria.
1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello e violazione dell’art. 291 c.p.c..
Prendendo le mosse dai “reiterati tentativi di notificazione dell’atto d’appello” al M.M., proprietario del veicolo su cui era trasportato I.I. – quattro tentativi in cui la notifica non si era perfezionata e infine l’ultimo perfezionatosi -, si espone quanto segue in ordine alla “scusabilità o meno dell’esito infruttuoso”.
1.1 La prima notifica, richiesta il 7 settembre 2017, per cui l’atto fu restituito con esito negativo il 15 settembre, era stata tentata in Sessa Aurunca, luogo dove con l’ordinaria diligenza il notificante avrebbe dovuto sapere che il destinatario non risiedeva più, dato che già nell’udienza del 17 novembre 2014 del primo giudizio il difensore degli attuali ricorrenti aveva dichiarato a verbale che era risultato sconosciuto all’indirizzo sia in tale Comune sia nel Comune di Formia e richiesto termine per il rinnovo della notifica dell’atto di citazione. Inoltre “l’appellante avrebbe potuto riproporre la notifica e non attendere supinamente” l’udienza del 9 gennaio 2018 sulla richiesta di sospensiva – in cui aveva chiesto e ottenuto dal giudice d’appello il rinvio (al 17 aprile 2018, prima udienza d’appello) per produrre la cartolina di ricevimento della prima notifica in quanto già il 15 settembre 2017 aveva ottenuto la restituzione dell’atto notificato come dimostrerebbe l’attestazione delle Poste allegata al ricorso. Avrebbe avuto ancora 109 giorni per tentare nuovamente la notifica, essendo stata fissata la prima udienza davanti al giudice d’appello il 9 gennaio 2018.
1.2 La seconda notifica era stata tentata il 24 maggio 2018 a Formia, dove il destinatario risultava irreperibile; il notificante sapeva o avrebbe dovuto sapere ciò, per quanto già detto in ordine alla precedente.
1.3 Per la terza notifica l’appellante aveva, prima di tentarla il 13 giugno 2018, atteso 17 giorni “per chiedere una certificazione anagrafica al Comune di Formia, ultima residenza nota”. Anche questa comunque non aveva avuto successo (era stata tentata nel Comune di Nettuno da cui il M.M. risultava trasferito).
1.4 Dopo l’esito infruttuoso della terza notifica il notificante aveva atteso 45 giorni prima di tentare il 27 luglio 2018 la quarta con il rito degli irreperibili (anche questa a Nettuno, ove il destinatario risultava sconosciuto).
1.5 Infine il 1 agosto veniva effettuato il quinto tentativo, ex art. 143 c.p.c., che giungeva al compimento.
1.6 Osservano i ricorrenti che il giudice d’appello “non ha affatto negato i principi di diritto” che essi avevano allora invocato, e cioè che quando la notifica non si perfeziona il notificante ha l’onere, per rispettare il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, di riattivare con solerzia il procedimento notificatorio senza attendere l”ordine del giudice (S.U. 24 luglio 2009 n. 17352), fruendo di un termine per la rinnovazione della notifica che corrisponde alla metà del termine ex art. 325 c.p.c. (si invocano S.U. 15 luglio 2016 n. 14594 e successiva giurisprudenza di legittimità). La corte territoriale ha tuttavia ritenuto rispettati tali principi, affermando che sarebbe stato “ripreso ogni volta il procedimento notificato in un termine pari alla metà di quello stabilito… dalla comunicazione dell’esito infruttuoso della precedente notifica”. Ciò, ad avviso dei ricorrenti, non sarebbe stato, in quanto Generali non avrebbe mai ripreso tempestivamente il procedimento notificatorio.
Tra la comunicazione dell’esito infruttuoso della prima notifica (15 luglio 2017) e il compimento del secondo tentativo (24 maggio 2018) sarebbero infatti trascorsi 251 giorni, fra la comunicazione dell’esito infruttuoso della seconda e il compimento del terzo tentativo (12 giugno 2018) 19 giorni, fra la comunicazione dell’esito infruttuoso del terzo e il compimento del quarto (27 luglio 2018) 45 giorni. Le prime quattro volte in cui Generali aveva tentato di notificare l’atto d’appello, essa “non solo non si è tempestivamente attivata per riprendere il procedimento… ma soprattutto ha compiuto quattro notifiche il cui esito infruttuoso è ascrivibile a negligenza” della notificante stessa, o per avere tentato in luoghi che ben sapeva non essere la residenza del destinatario, o per avere atteso più di 15 giorni dalla comunicazione dell’insuccesso del precedente tentativo prima di chiedere una certificazione anagrafica e reiterare la notifica.
Il giudice d’appello avrebbe pertanto violato l’art. 291 c.p.c. quando all’udienza del 17 aprile 2018, rilevato che Generali aveva atteso quasi sei mesi prima di rinnovare la notifica non perfezionata, le ha concesso l’ulteriore termine anzichè dichiarare inammissibile l’appello.
La corte territoriale avrebbe violato l’art. 291 c.p.c. anche laddove afferma che l’appellante aveva “ripreso ogni volta il procedimento notificato in un termine pari alla metà di quello stabilito”, il che “non è affatto vero”.
1.7 Peraltro il giudice d’appello avrebbe rigettato l’eccezione di inammissibilità del gravame in base a un’ulteriore ratio decidendi, ovvero ritenendo che il M.M. non era un litisconsorte necessario, per cui ogni omissione o decadenza in cui fosse incorsa l’appellante non avrebbe reso inammissibile l’appello, bensì meramente cagionata la scissione della causa rispetto alla posizione del M.M.; e ciò sulla base di tre rilievi.
In primo luogo, che sarebbero stati gli stessi attori nell’atto di citazione di primo grado ad affermare che il veicolo su cui viaggiava la vittima non era di proprietà del M.M., bensì del conducente H.H.; in secondo luogo, che il Tribunale aveva stabilito che il M.M. non era il proprietario dell’auto e quindi litisconsorte necessario; in terzo luogo, che tale statuizione del primo giudice era passata in giudicato in quanto non impugnata dagli attuali ricorrenti.
Tutte queste affermazioni sarebbero “manifestamente illegittime”.
1.8 Riguardo alla prima, violerebbe “il principio per cui gli atti di parte devono essere interpretati valutandoli nel loro insieme”; e, se è vero che a pagina 3 della citazione di primo grado gli attuali ricorrenti avevano – e sarebbe stato un evidente lapsus calami – affermato che il veicolo era “di proprietà e condotto da H.H.”, sarebbe altrettanto vero che, considerando l’atto nel suo insieme e soprattutto contestualizzandolo con gli altri atti processuali depositati dagli attori e con la loro condotta processuale, risulterebbe che gli attuali ricorrenti avevano citato davanti al Tribunale il M.M. quale proprietario del veicolo e pertanto responsabile in forza dell’art. 2054 c.c., comma 3.
La dimostrazione deriverebbe dal fatto che a pagina 26 della citazione si afferma che l’auto era del M.M., dal fatto che la citazione fu notificata a quest’ultimo, dal fatto che nell’epigrafe delle tre memorie ex art. 183 c.p.c. “M.M.” era sempre indicato dagli attori fra le parti in causa e dall’avere gli attori depositato fin dall’atto di citazione “un estratto cronologico del pubblico registro automobilistico, dal quale risultava che proprietario del veicolo al momento del sinistro era il suddetto M.M.”.
1.9 Inoltre, “a tutto concedere” si sarebbe dovuto applicare il principio per cui le ammissioni dell’avvocato non costituiscono confessione giudiziale ex art. 2732 c.c., in quanto questa richiede la disposizione del diritto, e l’avvocato non può disporre dei diritti del cliente.
1.10 Riguardo alla seconda affermazione del giudice d’appello – che la sentenza di prime cure avrebbe accertato la proprietà del veicolo in capo a H.H. -, sarebbe insostenibile in quanto raggiunta “trascrivendo una parte della sentenza di primo grado (pagina 4) nella quale il Tribunale non riferisce affatto la propria opinione”, limitandosi a riportare alcune circostanze emerse da una perizia penale prodotta agli atti.
Comunque anche le sentenze devono essere interpretate contestualmente, e nel caso in esame la sentenza di primo grado riconosce che il M.M. era parte del giudizio, nel dispositivo enuncia che la domanda è proposta anche nei suoi confronti, e non ha emesso alcuna pronuncia espressa di rigetto della domanda nei confronti del M.M..
1.11 Riguardo al terzo elemento, cioè che si sarebbe formato il giudicato nel senso che il M.M. non era proprietario dell’auto, sarebbe facilmente superabile dal rilievo che il Tribunale, come appena visto, ha dichiarato di pronunciare sulla domanda attorea nei confronti anche del M.M., e dall’ulteriore osservazione che, “anche a voler ammettere per assurdo che la sentenza di primo grado possa essere stata su questo punto ambigua, proprio tale ambiguità impediva di ritenere che la sentenza contenesse un accertamento della estraneità ai fatti di M.M., suscettibile di passare in giudicato”.
1.12 La Corte d’appello, poi, afferma che il primo giudice avrebbe implicitamente escluso che il M.M. fosse proprietario del veicolo “per il solo fatto di avere accolto la domanda di regresso” di Generali proposta soltanto verso gli eredi del conducente deceduto, H.H.; e dal momento che la sentenza del Tribunale non contiene al riguardo affermazioni esplicite, la mancata condanna del M.M. a rivalere Generali avrebbe costituito una omessa pronuncia di cui avrebbe dovuto dolersi la compagnia e non i danneggiati.
1.13 Inoltre la qualità di litisconsorte necessario deve stabilirsi in base alla domanda e, nel caso in esame, nella comparsa di risposta Generali aveva formulato domanda di regresso avverso gli eredi di H.H. nonchè nei confronti “del sig. M.M.”. Da ciò, essendo indiscusso che il H.H. era soltanto conducente, dovrebbe dedursi che la domanda nei confronti del M.M. si fondava sul suo essere proprietario del veicolo, e quindi proprio dalla domanda di regresso sarebbe emersa la sua qualità di litisconsorte necessario.
La Corte d’appello, affermando che Generali non era obbligata a rinnovare la notifica al M.M. e che questi non era proprietario del veicolo e dunque non era litisconsorte necessario, avrebbe pertanto “invertito l’ordine logico delle questioni di cui all’art. 276 c.p.c.”, accertando prima il merito (ed erroneamente, visto il certificato del P.R.A.) e solo dopo, sulla base di tale accertamento, ritenendo infondata l’eccezione pregiudiziale relativa alla inammissibilità dell’appello per mancata ripresa del procedimento notificatorio.
1.14 In conclusione, il giudice d’appello avrebbe erroneamente disatteso l’eccezione di inammissibilità del gravame proposta dagli appellati per avere “falsamente applicato” la giurisprudenza di legittimità sulla ripresa del procedimento di notificazione, avere “erroneamente attribuito agli attori” la volontà di confessare che il M.M. non era il proprietario del veicolo, avere erroneamente ritenuto che il primo giudice avesse accertato ciò e avere erroneamente sanato la tardività della notifica compiuta da Generali accertando, “ora per allora”, che il destinatario non fosse litisconsorte necessario.
1.15 Per dirimere questo assai esteso motivo, del tutto assorbente è rammentare che, anche se il M.M. fosse litisconsorte necessario – come in sostanza giungono a sostenere i ricorrenti qualora l’atto introduttivo non fosse stato correttamente notificatogli si sarebbe dovuto comunque applicare alla fattispecie l’art. 331 c.p.c..
Tale norma quindi sarebbe stata applicabile anche nel caso in cui fosse stata illegittima (e non si comprende, peraltro, perchè lo dovrebbe essere, considerato quanto si verrà ora ad evidenziare in ordine ai tentativi di notifica) l’assegnazione di un termine da parte del giudice d’appello all’appellante per rinotificare, assegnazione avvenuta nel caso in esame e che d’altronde ha dato luogo, senza che vi sia stato alcun superamento del termine concesso, ad una serie di tentativi tempestivamente ripresi: 90 giorni dal 17 aprile 2018 era infatti il termine dato dal giudice d’appello, per cui il primo 1:entativo avvenne il 24 maggio, il secondo il 12 giugno, il terzo il 27 luglio e infine la notifica avvenne il 1 agosto; un legittimo “allungamento in serie” per mancato perfezionamento, che non ha neppure integrato alcuna deviazione dall’insegnamento delle invocate Sezioni Unite.
Il motivo, dunque, non ha fondamento.
2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1223, 1227 e 2727 c.c., art. 13, comma 3, Direttiva 2009/103.
L’attribuzione da parte del giudice d’appello alla vittima di un concorso di colpa del 10%, in quanto “sapeva o doveva sapere” che il conducente del veicolo su cui saliva era intossicato da stupefacente sulla base del fatto che dall’autopsia era risultato che sia il guidatore sia egli stesso avevano assunto cocaina, costituirebbe violazione dell’art. 2727 c.c., del principio della causalità della colpa e dell’art. 13, comma 3, Direttiva 2009/103.
2.1 In riferimento all’art. 2727 c.c. si censura che il giudice d’appello avrebbe “accertato un fatto che non solo era singolo (ambedue le vittime avevano assunto cocaina…)” ma altresì non era grave, preciso e concordante, fondandosi solo su una mera congettura.
2.2 Riguardo poi alla causalità della colpa, necessaria per attribuire alla vittima un concorso di colpa, per affermare che vi era un nesso di causalità tra la scelta di quest’ultima di salire sul veicolo e la sua morte non sarebbe bastata la prova che il guidatore “fosse risultato positivo all’esame del narcotest”, perchè avrebbe potuto assumere stupefacenti in tempi del tutto diversi: “un’ora prima, oppure un giorno prima, od anche una settimana prima del sinistro”.
Si argomenta quindi sul reato di guida sotto l’influsso di stupefacenti (art. 187 C.d.S.), per sostenere poi che chi invoca la corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per avere accettato il passaggio da un conducente alterato da stupefacenti dovrebbe dimostrare che essa, secondo l’ordinaria diligenza, “ben si sarebbe potuta avvedere non già dell’assunzione di stupefacenti da parte del conducente, ma del fatto che tale assunzione aveva provocato uno stato di alterazione psicofisica”: e ciò non sarebbe stato accertato dal giudice d’appello, che “non riferisce quale fosse il livello di THC nel sangue del conducente; nè di quanto tale livello eccedesse la soglia minima di legge; nè dà conto delle modalità con cui fu effettuato il prelievo destinato al narcotest, nè quale fu il risultato di tale prelievo”. Non avendo pertanto “accertato in facto” se il conducente presentava sintomi di cui poteva avvedersi il trasportato, il giudice d’appello non avrebbe potuto affermare la sussistenza di una condotta colposa di quest’ultimo.
2.3 Ancora, la corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione del diritto comunitario, interpretando l’art. 1227 c.c. in contrasto con l’art. 13, comma 3, della Direttiva 2009/103/CE per cui “gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchè qualsiasi disposizione di legge… che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l’azione di tale passeggero”.
Si invocano CGUE 30 settembre 2003, causa C-224/2001, Koebler, e CGUE 13 giugno 2006, causa C-173/2003, Traghetti del Mediterraneo, in ordine al rispetto da parte del legislatore nazionale del diritto comunitario, nonchè CGUE, 30 giugno 2005, causa C-537/2003, Candolin, in ordine a tale direttiva.
2.4.1 Questo motivo ripropone, in sostanza, tematiche fattuali che sono state affrontate dal giudice d’appello, e che in questa sede di pura legittimità è inammissibile censurare. Tale inammissibilità i ricorrenti hanno tentato di schermare con riferimenti normativi che, però, rimangono inidonei a superare l’effettiva sostanza della censura, ovvero il perseguimento di un terzo grado di merito in quasi tutto l’ampio motivo.
Sono pertanto valutazioni fattuali proposte in via alternativa rispetto alle scelte accertatorie della corte territoriale le argomentazioni che criticano il riconoscimento del concorso di colpa del trasportato nella misura del 10%, che il giudice d’appello ha fondato sull’essere stato il trasportato consapevole che il guidatore aveva assunto cocaina. La raggiunta consapevolezza che il conducente era drogato e la imprudenza della condotta scelta nonostante ciò dal A.A. – ovvero decidere di essere comunque trasportato da un soggetto che aveva assunto cocaina – sono ovviamente valutazioni fattuali, che non possono essere confutate con riferimento alle norme invocate nella rubrica del motivo, collocandosi a monte rispetto alla loro applicazione. Esse d’altronde sono state motivate in modo sufficiente dal giudice d’appello, per cui il motivo non potrebbe neppure essere riqualificato come denunciante la carenza del minimo costituzionale in termini di motivazione.
2.4.2 Rimangono vagliabili invece le due tematiche che possono essere ricondotte anche ad una sostanza giuridica, cioè, in primo luogo, l’asserto che il giudice d’appello si sarebbe fondato esclusivamente su un fatto singolo e non anche grave, preciso e concordante, costituendo in realtà una mera congettura, e, in secondo luogo, l’applicazione, asseritamente mancata, della normativa unionale relativa all’assicurazione della persona trasportata in un veicolo guidato da una persona sotto effetti di alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro.
Riguardo alla prima doglianza, però, il suo contenuto non corrisponde a quel che in effetti emerge dalla sentenza impugnata, in quanto il giudice d’appello non si è fondato su una mera congettura, bensì (sentenza, pagine 22 s.) da più elementi che ictu oculi mera congettura non sono, cioè il riscontro dell’uso di cocaina e di cannabiniodi sia nel H.H. sia nel A.A. e in forte misura, ottenuto tramite gli “esami dei prelievi dei campioni di sangue ed urine effettuati nel corso delle autopsie” nonchè tramite la relativa valutazione presente nelle relazioni autoptiche dei consulenti del pubblico ministero, che hanno anche identificato l’epoca dell’assunzione degli stupefacenti (“nelle ore precedenti l’exitus”), cui ha per di più aggiunto la logica presunzione che “essendo risultato che entrambi i giovani avevano assunto stupefacenti poco prima del verificarsi dell’evento, in dosi elevate,… è verosimile che ciascuno fosse consapevole dello stato dell’altro”.
2.4.3 Quanto poi alla pretesa violazione della normativa unionale, la corte territoriale non vi è incorsa, interpretando correttamente la normativa, di per sè e nel sistema (sentenza, pagine 20ss.).
La corte ha dato atto che gli appellati avevano segnalato che all’epoca del sinistro “era già stata emanata la Direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, “Concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità”” e che l’art. 13, comma 3, della direttiva stabilisce: “Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinchè qualsiasi disposizione di legge… che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l’azione di tale passeggero nei confronti dell’assicuratore del responsabile o del Fondo di garanzia”; si è poi sintonizzata con Cass. sez. 3, 26 maggio 2014 n. 11698, il cui insegnamento nomofilattico preserva la rilevanza dell’esposizione volontaria al rischio ben correlandola, come chiave interpretativa dell’art. 1227 c.c., comma 1, al principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. e all’obbligo di responsabilità dei propri atti in esso insito, così insegnando: “L’esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all’ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonchè al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti”.
Alla luce di tale contestualizzazione nel sistema costituzionale della norma unionale invocata, non è difficile intendere detta norma nel senso che non esonera tout court il trasportato da ogni responsabilità della sua condotta, bensì gli garantisce comunque che gli effetti della sua responsabilità non pervengano all’assoluta esclusione dalla tutela assicurativa, che soltanto viene coordinata e calibrata con la sussistenza degli effetti di tale responsabilità se questa ricorre.
E una assoluta esclusione dalla copertura assicurativa, nel caso in esame, chiaramente non sussiste, essendo stata identificata dal giudice di merito la portata della responsabilità del trasportato nella assai tenue – quasi simbolica misura del 10%.
3. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 115, 167 e 342 c.p.c..
Espongono i ricorrenti che nel terzo motivo d’appello Generali aveva chiesto la diminuzione del risarcimento del danno non patrimoniale, e che gli allora appellati avevano eccepito l’inammissibilità della censura, sia perchè le difese sul punto di Generali in primo grado sarebbero state estremamente generiche e ciò avrebbe significato difetto di contestazione, sia perchè sarebbe stato violato l’art. 342 c.c.. Comunque gli appellati, nel caso in cui fosse ritenuto ammissibile il motivo di Generali, avevano evidenziato il proprio diritto ex art. 346 c.p.c. all’ammissione delle prove testimoniali proposte in primo grado e non ammesse dal Tribunale, prima che la Corte d’appello giudicasse se il quantum risarcitorio dovesse – come poi lo ha reputato essere “standard”.
La Corte d’appello ha però escluso la genericità della posizione assunta da Generali in primo grado e in appello, e “non ha provveduto in alcun modo” sulle istanze istruttorie degli appellati. Al riguardo, i ricorrenti presentano tre censure.
3.1.1 In primo grado, sarebbe erroneo il rigetto della eccezione di inammissibilità del terzo motivo d’appello ex art. 115 c.p.c., avendo la corte territoriale esclusa la genericità delle contestazioni di Generali perchè “anche il Tribunale le ha prese in esame” e perchè l’onere di contestazione andrebbe coordinato con il principio di prossimità della prova, “per cui la specificità della contestazione va valutata anche a seconda della prossimità del contestatore al fatto”.
Il primo argomento sarebbe giuridicamente rilevante e il secondo erroneo. Se è vero, infatti, che “in più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’onere di contestazione, stabilito dall’art. 115 c.p.c., viene meno per i fatti dei quali il convenuto non può essere a conoscenza”, ciò qui non sarebbe comunque pertinente. Gli attori in citazione avrebbero “analiticamente indicato le circostanze di fatto le quali rendevano il caso di specie diverso da quelli consimili” e quindi particolarmente grave il danno, specificando le circostanze per ciascuno dei quattro danneggiati. Generali nella comparsa di risposta non avrebbe mai contestato che tali circostanze “giustificassero la personalizzazione del risarcimento”. Pertanto il giudice d’appello avrebbe “falsamente applicato il principio secondo cui il convenuto non ha l’onere di contestare i fatti dedotti dall’attore, se questi rientrino nella sfera di conoscibilità unicamente di quest’ultimo”, in quanto tale principio sarebbe stato applicabile solo “se vi fosse stata controversia tra le parti circa la verità o la falsità dei fatti dedotti dall’attore”, il che non sarebbe stato il fondamento del terzo motivo d’appello.
3.1.2 Inoltre la corte territoriale avrebbe erroneamente applicato il principio per cui il convenuto non ha l’onere di contestare i fatti conoscibili solo dall’attore, giacchè nel settore dell’assicurazione obbligatoria della circolazione dei veicoli le condizioni della vittima non sarebbero un “fatto estraneo alla conoscenza del convenuto” in quanto l’assicuratore o l’impresa designata avrebbero, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ex art. 148 “il preciso dovere.. di attivarsi, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento…, per istruire la relativa pratica, e di acquisire, esaminare e valutare con diligente solerzia tutti gli elementi” presentati dal preteso danneggiato, per concludere con una offerta di risarcimento “congrua e motivata”. Se Generali non aveva adempiuto al proprio dovere, non poteva essere “sollevata dall’onere di contestazione analitica dei fatti dedotti dagli attori” di cui all’art. 115 c.p.c., essendosi essa stessa posta volontariamente nella condizione di non conoscerli.
3.2 In secondo luogo, sussisterebbe erroneo rigetto dell’eccezione di inammissibilità del terzo motivo d’appello ex art. 342 c.p.c..
Del terzo motivo d’appello la corte territoriale ha accolto la doglianza di eccessivo quantum, che peraltro non sarebbe stata conforme alle prescrizioni dell’art. 342 c.p.c., non indicando “quali circostanze riduttive del danno non siano state considerate dal primo giudice” e neppure “quali circostanze amplificative del danno siano state erroneamente ritenute sussistenti dal primo giudice”.
Inoltre il terzo motivo d’appello era inammissibile rispetto all’art. 342 c.p.c. “se confrontato con il contenuto della sentenza di primo grado”, in cui erano state dedicate ben dieci pagine di motivazione per spiegare perchè si concedeva risarcimento in misura superiore alla media, il che non sarebbe stato confutato nella censura de qua, costituente un motivo puramente assertivo nel senso che “il Tribunale aveva liquidato troppo”.
3.3 Il terzo profilo del terzo motivo del ricorso consiste nell'”omessa pronuncia sulle istanze istruttorie” – rappresentate dai capitoli arl:icolati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, tutti trascritti nelle pagine 4547 del ricorso – riproposte all’udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado, che il Tribunale non avrebbe ammesso “non perchè inammissibili, ma perchè superflue”, in quanto si sarebbe avvalso della prova presuntiva ai sensi dell’art. 2727 c.c..
Gli appellati avevano nuovamente chiesto la loro ammissione, e “tale richiesta non necessitava di un appello incidentale”, essendo essi vittoriosi. La corte territoriale “non ha mai provveduto espressamente”, per cui al giudice di legittimità si aprirebbero due strade: o ritenere che vi sia stato un implicito rigetto – e allora la sentenza sarebbe “doppiamente viziata”, essendo la prova ammissibile e rilevante e non avendo alcuna motivazione il suo disattendimento -, o reputare che il giudice d’appello “abbia puramente e semplicemente dimenticato di provvedere” – e allora sussisterebbe violazione dell’art. 112 c.p.c..
3.4 Il motivo, come si è visto, è particolarmente ampio, ma nonostante la pluralità delle argomentazioni non gode di alcuna consistenza.
3.4.1 In relazione, allora, all’asserto del difetto di contestazione da parte di Generali e comunque di assunzione di una posizione di contrasto generico da parte della compagnia rispetto al quantum del risarcimento, va rilevato che la corte territoriale ha affermato – opponendo ciò al medesimo asserto già fin d’allora inserito dagli attuali ricorrenti nella loro difesa di appellati – che Generali aveva apportato nella comparsa di risposta e nei successivi scritti difensivi una contestazione sufficiente (sentenza, pagina 28).
E infatti, come ha rimarcato Generali nel suo controricorso (pagina 20), dalla comparsa di costituzione e risposta di primo grado emerge una presa di posizione adeguata, sostanzialmente corrispondente, è ovvio, a quel che è divenuto poi contenuto di una censura del gravame: “In ordine al quantum debeatur, si contesta la quantificazione dei danni proposta da controparte, siccome palesemente sproporzionata rispetto all’entità degli stessi, con riserva di ulteriormente dedurre sul punto allorchè le controparti avranno meglio precisato, e comunque provato, la sussistenza dei danni lamentati. In ogni caso, ferma restando la contestazione del diritto al risarcimento di voci non dovute e non provate quale il danno biologico iure ereditario, il danno patrimoniale, il danno biologico iure proprio patito dai genitori del de cuius si rileva, spiegando formale eccezione, che giammai la comparente potrà essere tenuta al risarcimento di una somma superiore al massimale…”.
Quindi la contestazione non era paralizzata in un’assoluta genericità, bensì, al contrario, rapportata chiaramente a tutte le voci di danno.
Lo sviluppo naturale di tale contestazione al termine del primo processo e sulla soglia pertanto della sentenza del tribunale è poi attestato dalle ampie argomentazioni che al riguardo sono state dedicate nella comparsa conclusionale di Generali appunto in primo grado (corrispondenti a quanto da essa qui trascritto nel controricorso, pagine 21-29).
L’affermazione che in primo grado le difese in tema risarcitorio di Generali sarebbero state estremamente generiche e quindi non avrebbero integrato un’adeguata contestazione, lasciandola invece mancante, viene dunque smentita. E parimenti risulta smentita anche la pretesa violazione dell’art. 342 c.p.c., considerato il contenuto effettivo del terzo motivo d’appello (anche questo corrispondente a quel che riporta il controricorso, pagine 30-38).
Da quanto appena osservato discende la caduta della censura ex art. 115 c.p.c., giacchè le contestazioni di Generali non erano generiche, per cui non rileva l’inciso motivazionale “anche il Tribunale le ha prese in esame”; per le stesse ragioni, non rileva neppure l’invocazione del principio di prossimità della prova, avendo adeguatamente contestato Generali nella sua posizione di convenuto ciò che era stato addotto dalla controparte attrice.
3.4.2 Per quel che riguarda, infine, la censura sull’omessa pronuncia delle istanze istruttorie, a tacer d’altro, è implicito e comunque del tutto logico nella complessiva motivazione offerta sul tema de quo dalla sentenza d’appello avere ritenuto irrilevanti, anche se espletate, tali prove, valutazione, questa, chiaramente fattuale. Non ricorre neppure, dunque, a ben guardare, alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c..
4. Il quarto motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1223 e 2059 c.p.c. (evidente lapsus calami in luogo di c.c.).
Si affrontano le riduzioni del risarcimento del danno patrimoniale da perdita del congiunto espletate dalla corte territoriale rispettivamente ai risarcimenti dei genitori, del fratello e del nonno del deceduto, sostenendo che la motivazione posta a sostegno sarebbe “viziata sotto tre profili”: travisamento degli atti, natura tautologica e incoerente, violazione dell’art. 1223 c.c..
4.1 In primis, si rileva che il giudice d’appello non avrebbe mai messo in dubbio la verità delle circostanze di fatto indicate nell’atto di citazione di primo grado sulle conseguenze che i parenti avevano patito per la morte del congiunto, e pertanto avrebbe commesso un travisamento degli atti per averle poi considerate conseguenze “del tutto usuali” del lutto.
4.2 In secondo luogo, la motivazione con cui è stata accolta la censura di Generali sarebbe nulla per inferiorità al minimo costituzionale. Si baserebbe infatti, una volta “sfrondata di tutte le citazioni”, su “due affermazioni”, cioè: “le circostanze dedotte dagli attori a fondamento della domanda di personalizzazione del risarcimento non sono circostanze speciali, ma conseguenze “del tutto usuali” in ogni famiglia colpita dal lutto; di conseguenza la decisione adottata non risulta conforme all’insegnamento della suprema Corte (…) perchè la perdita di un congiunto è meglio tollerata in una famiglia numerosa”.
Non vi sarebbe alcuna connessione logica tra la premessa (la usualità) e la conseguenza (la miglior tolleranza in famiglia numerosa). Inoltre una motivazione siffatta non raggiungerebbe il minimo costituzionale.
4.3 In terzo luogo, sussisterebbe una falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., per cui il risarcimento del danno deve includere sia la perdita subita sia il mancato guadagno.
Il giudice d’appello “ha accertato in punto di fatto che ambedue i genitori… hanno patito una malattia psichica in conseguenza della morte del figlio”; e “tale malattia psichica è stata liquidata a parte, sub specie di danno biologico”. Però, avendo accertato che entrambi i genitori si erano ammalati, il giudice d’appello avrebbe dovuto dedurne che il caso di specie non era “standard”, non essendo una conseguenza “del tutto usuale” della perdita del figlio: pertanto sarebbe stato falsamente applicato l’art. 1223 c.c..
4.4 L’effettiva sostanza del motivo, nella sua maggior parte, pur “mascherata” quale denuncia di violazione degli artt. 1223 e 2059 c.c. come insita nella riduzione di questo danno non patrimoniale, consiste evidentemente, in realtà, in una pura questione di fatto, per cui si intenderebbe ottenere una valutazione alternativa appunto delle conseguenze fattuali pregiudizievoli che la morte del de cuius avrebbe apportato ai familiari.
4.5 Laddove, poi, si argomenta (il che non è peraltro neppure menzionato nella rubrica) per dimostrare la presenza di una motivazione inferiore al minimo costituzionale, i ricorrenti si avvalgono di estrapolazioni artificiose dal tessuto motivazionale, o anche di una parte ictu oculi non pertinente della massima di un arresto di legittimità (Cass. 3581/2010) richiamata dalla corte territoriale; che poi questa abbia erroneamente rimarcato in grassetto tale parte l’argomento sulla famiglia numerosa – non giunge certo a privare del minimo costituzionale la complessiva motivazione con cui ha sorretto, in sostanza, la propria constatazione – si ripete, di puro merito – di non avere rinvenuto peculiarità alcuna nell’entità del danno subito dai parenti per la perdita del de cuius riconducendone pertanto la quantificazione risarcitoria ad una entità media nell’ambito della forbice tabellare.
4.6 Quanto infine alla questione del danno biologico psichico, gli stessi ricorrenti ammettono che è stato liquidato a parte come risarcimento appunto di danno biologico, il che è già sufficiente a privare di consistenza l’argomentazione con cui tentano di richiamarlo quale ragione per superare lo standard tabellare di un’altra species di danno, non essendo certo prospettabile un bis in idem risarcitorio per quel che rimane in effetti un medesimo pregiudizio.
5. Il quinto motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “erroneo rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale” e violazione dell’art. 1223 c.c..
5.1 Osservano i ricorrenti che nell’atto di citazione di primo grado si era esposto che il de cuius, “sin da giovanissimo”, aveva partecipato alle attività di gestione di un bar che costituiva impresa familiare, e così portato alla famiglia il suo contributo patrimoniale. Controparte non l’avrebbe contestato, in quanto aveva ribattuto come segue: “in ordine al quantum debeatur, si contesta la quantificazione dei danni…, siccome palesemente sproporzionata rispetto all’entità degli stessi, con riserva di ulteriormente dedurre sul punto allorchè le parti avranno meglio precisato, e comunque provato, la sussistenza dei danni lamentati”.
Gli attori avrebbero poi depositato la certificazione della cessazione dell’attività commerciale della competente Camera di Commercio, e richiesto di provare in via testimoniale la collaborazione di I.I. alla gestione del bar da quando aveva quattordici anni; senza ammettere le prove, il primo giudice aveva riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale nella misura di Euro 100.000.
Avverso questo capo della sentenza, Generali aveva proposto appello, accolto dalla corte territoriale che, dato per “incontroverso” che il giovane “desse una mano nel bar di famiglia”, ha ritenuto che il suo lavoro potesse ricondursi ai doveri di cui all’art. 315 c.c., e affermato che non era stata data prova di un “costo di rimpiazzo”, non essendo stata nè addotta nè provata l’assunzione di un nuovo collaboratore.
5.2 In primis si assume che il giudice d’appello sarebbe incorso in un lapsus calami per aver fatto riferimento al non pertinente art. 315 c.c. anzichè all’art. 315 bis c.c. Fondandosi allora sull’art. 315 bis, u.c. – per cui “il figlio… deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa” – i ricorrenti sostengono che la decisione del giudice d’appello è anzitutto illegittima per falsa applicazione dell’art. 315 bis, introdotto dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, in vigore dal 1 gennaio 2013, e quindi posteriore al decesso avvenuto nel sinistro del 15 aprile 2011.
5.3 In secondo luogo, i ricorrenti attribuiscono al giudice d’appello la violazione degli artt. 1223 e 2043 c.c. per avere “affermato che, avendo il figlio… il dovere giuridico di collaborare dell’impresa familiare, la sua morte non avrebbe arrecato alcun danno patrimoniale”: affermazione sia illegittima sia illogica, facendo dipendere la risarcibilità del danno rappresentato dalla “perduta possibilità di avvalersi del lavoro svolto dell’impresa familiare da uno dei familiari” non dall’esistenza del danno, bensì dal titolo per cui si fruiva delle prestazioni lavorative del de cuius, titolo che invece non avrebbe incidenza sulla utilità perduta in conseguenza del fatto illecito.
5.4 Ancora, si censura l’ulteriore affermazione che il danno non era stato dimostrato per difetto di prova del “costo di rimpiazzo”, cioè la prova “di avere assunto un nuovo collaboratore”. L’affermazione, infatti, sarebbe erronea in quanto contraddittoria con la precedente affermazione che era incontroverso che il de cuius collaborasse nel bar di famiglia, e contrasterebbe con l’art. 1223 c.c. che identifica il danno in senso giuridico anche nella “perdita di una utilità”; e “la perdita di una utilità economica non cessa di essere un danno risarcibile sol perchè il danneggiato non provveda a ripristinare il bene perduto o a procacciarsi aliunde l’utilità venuta meno”.
La corte, quindi, avrebbe commesso due errori di diritto: il primo nell’affermare che la morte di un familiare lavorante nell’impresa di famiglia non costituisca un danno patrimoniale perchè il lavoro nell’impresa di famiglia “costituirebbe un dovere e non una facoltà”; il secondo nell’affermare che per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale occorre provare il costo del rimpiazzo dell’utilità perduta.
5.5 In subordine alle precedenti doglianze, i ricorrenti qualificano nulla la sentenza laddove dapprima ha ritenuto non provata la perdita di una unità di forza-lavoro per la morte di I.I., ma poi ha rifiutato di ammettere la prova testimoniale che era stata chiesta in primo grado e reiterata in appello, relativa al suo lavoro continuativo nell’impresa familiare.
5.6 In primo luogo, deve osservarsi che il giudice d’appello non ha compiuto alcun lapsus calami richiamando l’art. 315 c.c. in luogo dell’art. 315 bis c.c., ratione temporis qui non applicabile come gli stessi ricorrenti ammettono.
Il testo dell’art. 315 c.c. applicabile in quanto vigente all’epoca della morte di I.I., cioè nel 2011, stabilisce che il figlio “deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa” (dettato poi trasferito nell’art. 315 bis c.c., u.c. introdotto dalla L. 10 dicembre 2012 n. 219, con l’unica aggiunta del riferimento anche alle “capacità” del discendente).
La corte territoriale ha preso le mosse dal riconoscimento che il de cuius contribuiva, dichiarando che sarebbe un fatto “incontroverso”, ma ciò nonostante, con un’argomentazione alquanto singolare, ha escluso ogni risarcimento, così esprimendosi:
“Ebbene, pur volendo considerare incontroverso che il A.A. abbia “dato una mano” nel bar di famiglia, tale collaborazione nella specie ben può ricondursi nell’ambito dei doveri di cui all’art. 315 c.c., tant’è vero che non risulta giammai dedotto che per tale attività sia stato retribuito. Soprattutto, neanche è provato che la sua morte abbia comportato la perdita di una unità di forza-lavoro e che, quindi, i coniugi abbiano sostenuto il c.d. costo di rimpiazzo… non risultando nè dedotta, nè provata l’assunzione di un nuovo collaboratore (avendo, anzi, gli odierni appellati allegato di aver deciso di interrompere l’attività commerciale).
A fronte di tali risultanze, la decisione gravata non è conforme all’insegnamento della S.C. (secondo cui “ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, patito dai coniugi per la morte del figlio in conseguenza del fatto illecito altrui, è necessaria la prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragionevolmente probabilistici, che essi avrebbero avuto bisogno della prestazione alimentare del figlio, nonchè del verosimile contributo che il figlio avrebbe versato per le necessità della famiglia”: Cass. 16.1.2014 n. 759) in quanto non risulta provato nè che i genitori abbiano avuto bisogno di sostegno, nè che abbiano ricevuto l’aiuto economico del defunto, apparendo semmai verosimile il contrario”.
5.7 Le argomentazioni del giudice d’appello contraddicono quel che era stato il suo punto di partenza nell’affrontare il relativo motivo di gravame di Generali, cioè l’essere “incontroverso” che il de cuius aveva “dato una mano” nell’impresa familiare (il “bar di famiglia”). Da tale asserto, pur espresso con una modalità, per così dire, minimalista (“dato una mano”), discende infatti, che il figlio aveva collaborato in tale attività: e infatti subito dopo il giudice d’appello abbandona la sua espressione minimalista per riconoscere una vera e propria “collaborazione” e ricondurla all’adempimento dei doveri ex art. 315 c.c. (“tale collaborazione nella specie ben può ricondursi nell’ambito dei doveri di cui all’art. 315 c.c.).
Dunque, I.I. aveva collaborato all’impresa di famiglia; e la sua collaborazione, di natura intrinsecamente economica come è sempre un’attività lavorativa, era venuta meno per il suo decesso. Non si vede, allora, come si possa negare che ciò abbia procurato un danno patrimoniale. Il danno patrimoniale, infatti, trova la sua natura nella perdita una deminutio – di quel che anteriormente, in senso contrario, costituiva un plus economico a favore del danneggiato.
5.8 L’invocata Cass. sez. 3, 16 gennaio 2014 n. 759 non è affatto pertinente con la tematica in esame: essa, invero, concerne la diversa questione del diritto agli alimenti, e in generale dei “bisogni”, ontologicamente diversa da quella che qui si tratta – in motivazione, invero, richiama i “principi espressi da questa Suprema Corte secondo i quali ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro derivante dalla perdita degli alimenti che il figlio avrebbe potuto erogare in favore dei genitori o del genitore superstite, questi devono provare che, sulla base delle circostanze attuali, secondo criteri non ipotetici, ma ragionevolmente probabilistici, essi avrebbero avuto bisogno di tale prestazione alimentare; allo stesso modo, va provato il verosimile contributo del figlio ai bisogni della famiglia, ove dedotto per il futuro (cfr. Cass. n. 4791/07 e n. 9546/08)” -. E infatti la Corte d’appello, discostandosi dal reale contenuto del thema decidendum quantomeno dove inserisce il “bisogno di sostegno”, conclude il suo vaglio del motivo adducendo che “non risulta provato nè che i genitori abbiano bisogno di sostegno, nè che abbiano ricevuto l’aiuto economico del defunto, apparendo semmai verosimile il contrario”, così pure contraddicendo se stessa rispetto all’incipit del percorso argomentativo, laddove aveva – come si è visto – espressamente riconosciuto che il de cuius aveva dato “collaborazione” all’impresa di famiglia.
Nè, d’altronde, è sostenibile – come pure adduce con un rapido inciso la corte che la perdita di una prestazione economicamente valevole non costituisca danno perchè tale prestazione era dovuta a titolo gratuito: la gratuità per chi rende della debenza della prestazione non espunge, infatti, per chi la riceve il valore patrimoniale della prestazione stessa, e dunque la sua perdita altera – a ben guardare, anche in misura superiore che per una prestazione a pagamento, necessitante infatti un corrispettivo – in senso diminutivo la complessiva sfera giuridica di quest’ultimo, id est le crea un danno emergente.
5.9 Non è poi comprensibile l’ulteriore argomentazione adottata dal giudice d’appello relativa a un difetto di prova della “perdita di una unità di forza-lavoro e che, quindi, i coniugi abbiano sostenuto il c.d. costo di rimpiazzo” assumendo un altro collaboratore. Correttamente, invero, i ricorrenti in questo motivo si sono fondati sull’art. 1223 c.c., che la corte territoriale dimostra, qui, di non applicare correttamente.
L’art. 1223 ripartisce l’obbligo di risarcimento del danno tra il danno emergente e il lucro cessante, che rispettivamente qualifica “perdita subita” e “mancato guadagno” in un collocamento causale immediato e diretto. La ratio, come è ben noto, è di pervenire ad un totale ripianamento della sfera giuridica lesa al danneggiato; il che, tuttavia, non significa esigere una ricostruzione assolutamente identica alla sfera giuridica anteriore al pregiudizio effettuata da parte del danneggiato stesso. Quest’ultimo, infatti, non è tenuto ad attivarsi in tal senso, potendo optare per un ripianamento compiuto direttamente “per equivalente” tramite appunto una pretesa risarcitoria che non è a monte vincolata da un anteriore presupposto di recupero per cui il danneggiato stesso si debba attivare.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte da tempo insegna, a proposito del risarcimento del danno da fatto illecito, che detto risarcimento “ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo stesso e, quindi, trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita da quel patrimonio, in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati” (così, tra gli arresti massimati, Cass. sez. 2, 5 luglio 2002 n. 9740 e Cass. sez. 3, 3 ottobre 1987 n. 7389; e cfr. anche, pur in fattispecie non del tutto coincidenti, Cass. sez. 2, 10 marzo 2016 n. 4718 e Cass. sez. 3, 10 novembre 2010 n. 22826 per cui la “perdita subita” ex art. 1223 c.c. non può considerarsi indicativa solo degli esborsi monetari già effettuati, ma anche di quelli futuri).
Non ha dunque alcun rilievo, a differenza di quel che sostiene la corte territoriale, il fatto che il de cuius sia stato sostituito con un “costo di rimpiazzo”, nè tantomeno rileva che i danneggiati abbiano “deciso di interrompere l’attività commerciale”. Queste argomentazioni, con cui il giudice d’appello, a ben guardare, respinge l’an del danno, confliggono, come si è appena visto, con il dettato dell’art. 1223 c.c. Nè tantomeno è condivisibile la pretesa, per “aprire le porte” al risarcimento, di provare che la morte di I.I. abbia comportato perdita proprio di “una unità di forza-lavoro”, non occorrendo che la “collaborazione” resa nella impresa familiare raggiungesse un livello quantitativo pari all’attività lavorativa che avrebbe posto in essere una persona assunta (“l’assunzione di un nuovo collaboratore”).
La Corte d’appello, pertanto, non ha applicato in modo corretto l’art. 1223 c.c., e così ha erroneamente escluso il danno patrimoniale relativo alla perdita della collaborazione del de cuius all’impresa di famiglia.
Al riguardo, dunque, accogliendosi il quinto motivo del ricorso la sentenza deve essere cassata, con rinvio – anche per le spese processuali – alla stessa corte territoriale in diversa sezione e diversa composizione, la quale dovrà applicare il seguente principio di diritto: per ottenere il risarcimento della “perdita subita” ai sensi dell’art. 1223 c.c. non occorre che il danneggiato si sia preventivamente attivato per ripianare detta perdita così da dimostrare di avere sostenuto le spese allo scopo necessarie, non sussistendo alcuna obbligazione in tal senso.
Accoglie il ricorso limitatamente al quinto motivo, disattesi gli altri, cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli.
- ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO Conducente sotto effetto di alcol o sostanze eccitanti - Consapevolezza del trasportato - Art. 13 Direttiva 2009/103/CE - Esclusione del diritto alla tutela assicurativa - Insussistenza - Esposizione volontaria al rischio - Incidenza nell'eziologia dell'evento dannoso ex art. 1227, comma 1, c.c. - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie..
- Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE del 2009 num. 103 art. 13.
Mi auguro che questo post ti sia utile e ti ricordo che ogni articolo – grazie anche alla collaborazione dei lettori – viene costantemente aggiornato e approfondito nel tempo al fine di offrire una guida quanto più completa ed esaustiva possibile.
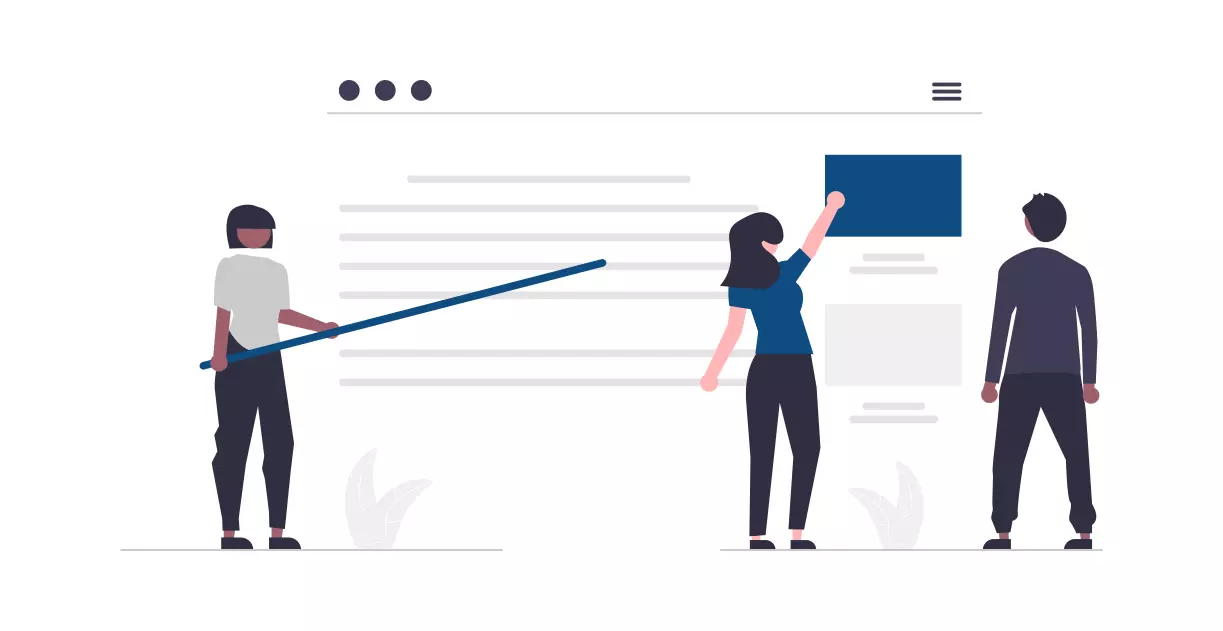
La tua opinione conta. Miglioriamo insieme il Progetto.
Hai opinioni, pareri, correzioni da condividere su questo argomento?
Faccelo sapere! Il nostro obiettivo è offrire i migliori contenuti possibili.
Apprezziamo qualsiasi feedback ben argomentato.